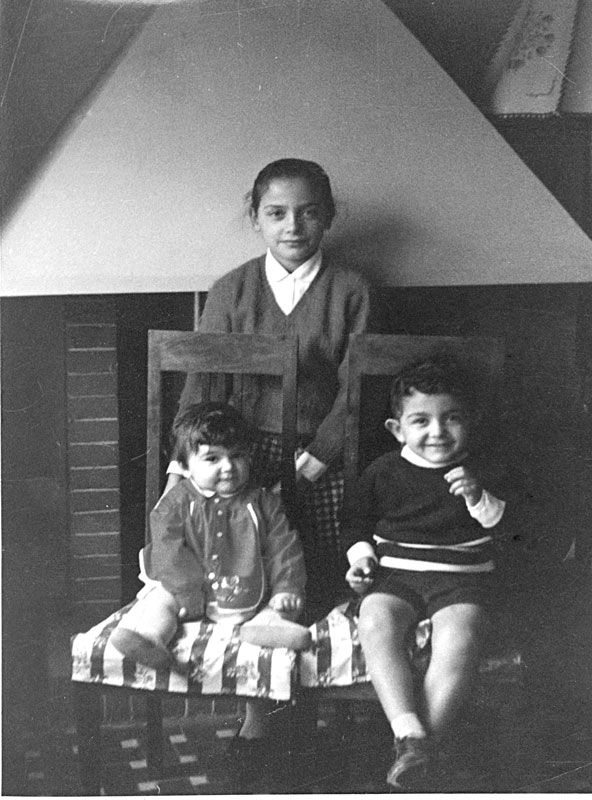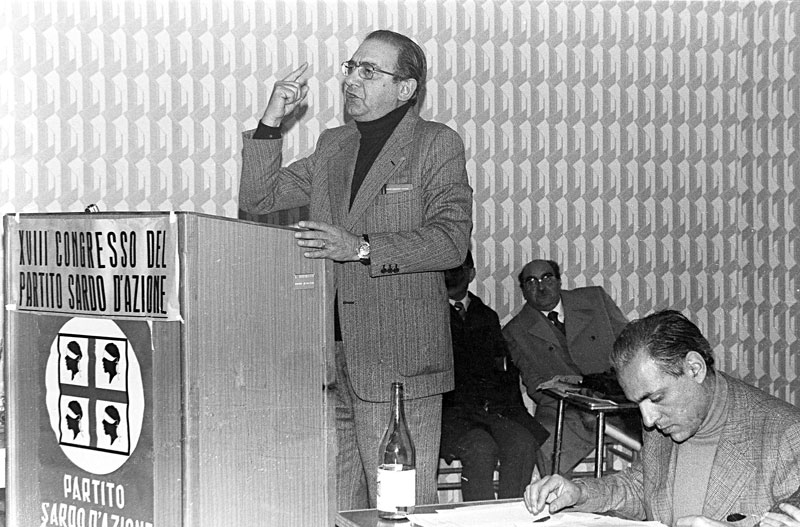Nuoro, 5 marzo 2002
Una corrente di pensiero politico mette in discussione l’attualità degli statuti speciali riconosciuti dalla Costituente alle Regioni Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia in vista del loro superamento con la riforma federalista dello Stato.
Il ragionamento, apparentemente logico, riduce il tema nei ristretti spazi di uno schematismo così semplicistico da sconfinare nel falso.
La ragion d’essere dello Stato, infatti, si concentra nell’articolazione ed esercizio del potere legittimo fra le diverse istituzioni e cittadini che lo costituiscono.
Quando il potere è allocato ai vertici tanto le istituzioni territoriali che i cittadini assumono ruolo subalterno di semplici destinatari delle decisioni assunte in sede di Governo centrale. Tale concezione affonda le sue radici nello Stato Giacobino affermatosi con la Rivoluzione Francese e contrasta con la tesi federalista per la quale tutto il potere appartiene al popolo che lo esercita attraverso le istituzioni della democrazia di base, delegando agli organi centrali solo quelle funzioni e competenze per loro natura non frazionabili fra le istituzioni territoriali. A dare palpito unitario allo Stato è la solidarietà che considera le diversità arricchimento reciproco.
Ciò premesso osservo:
1° la specialità dello statuto deriva dal formale riconoscimento da parte della comunità italiana della diversità Sarda non solo economico-geografica ma etno-storica non riconducibile entro i normali parametri validi per le altre regioni; specialità da aggiornare ed arricchire come specificato nella parte conclusiva di questo scritto.
2° l’ipotesi della futura riforma federalista s’impaluda nelle sabbie mobili di un dibattito estremamente confuso, contraddittorio ed incoerente rispetto ai principi fondanti dello Stato federalista.
La Lega lombarda ad esempio, ne individua – in accordo con la prevalente dottrina – la legittimazione nella genesi contrattuale dello Stato quale sede di incontro di interessi e convenienze la cui mancanza – anche parziale – è motivo sia di recessione che di scioglimento. Una tale interpretazione è però arbitraria e gravemente lesiva della forza interiore che è all’origine e nelle finalità dello Stato Federale garantire la pace , la solidarietà che sono pilastri fondanti e le reali motivazioni che ne legittimano la costituzione.
L’incoerenza dell’assunto si scontra con l’altra componente della stessa coalizione di cui fa parte la Lega: Alleanza Nazionale, erede della concezione centralistica della sovranità considerata unica garante di ordine, disciplina ed indissolubile unità dello Stato. In nome di tali principi considera le “diversità” momento disgregante dell’unità e perciò da combattere.
Evidente l’antitesi fra le due concezioni; sostanzialmente contrarie, per opposti motivi, allo Stato federale;
3° della stessa coalizione, oltre, due partiti cattolici manifestamente subalterni a Forza Italia fa parte, con ruolo di guida, Forza Italia, la cui dottrina si lega al pensiero del suo fondatore che però, pur prodigo di proclami, di dottrina dello Stato non mostra interesse alcuno. Concentra la sua veemente oratoria nell’accusare di stalinismo gli avversari ignorando disinvoltamente la dissoluzione della Russia sovietica, il crollo del muro di Berlino ed il fatto che i paesi “ex-satelliti” affollano le anticamere dell’Unione Europea chiedendone l’ammissione, o quanto meno lo status di socio in prova attraverso trattati commerciali e soccorsi di vario genere.
La verità è che Forza Italia, tumultuosamente sviluppatasi intorno alla figura del suo fondatore sotto la spinta emotiva dello sdegno suscitato dalla verminaia di corruzione politica messa a nudo da “mani pulite”, lungi dall’approfondire linee programmatiche ed ipotesi di riforma dello Stato, sembra interessata pressoché esclusivamente ai traguardi elettorali per la cui conquista mobilita forze eterogenee e promette tutto ed il suo contrario dall’aumento delle pensioni, alla riduzione degli oneri fiscali in uno all’aumento dell’occupazione nell’ordine del milione d’unità. Si affida insomma all’attesa miracolistica della gente. Parla bensì di federalismo ma nei fatti non ne precisa struttura e ruoli istituzionali; in sostanza lo combatte. Basti pensare al come abbia fatto fallire il tentativo della commissione D’Alema della quale principale relatore federalista era peraltro un autorevole esponente del Polo delle Libertà, l’on. D’Onofrio.
4° Né – sull’altro versante – convince la legge d’iniziativa del governo definita “federalista” ma che del federalismo manca di requisiti essenziali: la Camera pariteticamente rappresentativa delle Regioni e la Corte Costituzionale formata, nei giudizi sui conflitti di competenza fra Governo centrale ed una o più Regioni, da un numero di magistrati eletti per metà dagli organi centrali dello Stato e per l’altra metà dall’assemblea dei Presidenti delle Giunte o Consigli regionali o da entrambi.
Il problema non si esaurisce infatti nel solo conferimento alle istituzioni federate di poteri più o meno ampi, ma si realizza: 1° nella certezza che tali poteri non siano revocabili ad libitum del Governo centrale; 2° nel coinvolgimento delle Regioni al momento formativo della volontà legislativa nazionale.
In mancanza di tali requisiti, 1° non esiste terziarietà del giudice costituzionale che, eletto da una delle parti in contesa se ne sente naturale rappresentante e tutore e 2° le istituzioni regionali perdono il carattere di soggetti dotati di poteri originari restando – come ancor oggi – destinatarie subalterne della legislazione quadro (quando non anche settoriale), deliberata dal Parlamento nazionale dal quale sono estromesse.
Queste considerazioni non inficiano comunque la rilevanza politica ed il valore regionalista della legge in discussione. È un importante passo avanti ma, sia chiaro: non è il federalismo.
Si va infine diffondendo la tesi che lo status di soggetto federato, oltre che alle istituzioni regionali, vada esteso ai grandi comuni sulla cui storia si fonderebbe la tradizione italiana.
Ebbene va detto a chiare lettere che una tale promiscuità è non solo antitetica ma paralizzante del vitale operare solidaristico dello Stato federale.
Anzitutto il presupposto è falso.
La storia italiana non si fonda affatto su tradizioni municipali ma su forti e consolidate statualità. Alcuni esempi: il Regno di Federico II cui, sia pure in tempi diversi, è seguito il Regno delle due Sicilie esteso da Palermo a Gaeta; lo Stato del Vaticano che da Gaeta giungeva nella pianura Padana ricomprendendo Bologna; il Gran Ducato di Toscana; il Principato di Piemonte, il Regno di Sardegna, le Repubbliche di Genova e Venezia. È bensì vero che alcuni Stati prendevano il nome dal Comune capoluogo come ad esempio la Firenze dei Medici, la Repubblica di Pisa, il Comune di Milano i cui governi non si esaurivano però fra le mura cittadine; Milano ad esempio estendeva la sua amministrazione dalla Lombardia oltre lo Stelvio ricomprendendo territori oggi facenti parte della repubblica Elvetica (giungeva a Locarno).
Governi che esercitavano con eguale autorevolezza politica sia interna che internazionale assolvendo a ruoli di grande prestigio specie in materia economico-finanziaria, culturale, primeggiando in Europa in alcuni settori quali il bancario e l’industriale (rigorosamente protetti dal segreto di fabbrica, come ad esempio in campo tessile) mostrava l’inesistenza storica del presupposto.
Osservo per contro come lo stato federale si articoli e realizzi in stati federati nel cui territorio è insediato un popolo unito da esperienze, interessi economici, culturali, valori etici, tradizioni, usi e costumi così peculiari da farne emergere soggettività etno-storica unica e diversa (ma non per questo antitetica) rispetto a quella degli altri stati componenti la stessa federazione. Salvo la Città-Stato di Amburgo (che vanta autonomia sin dal 1241 – e trattò a suo tempo l’adesione all’impero germanico salvaguardando il suo status di autonomia interna ed internazionale), non mi risulta alcun altro esempio di città europea avente condizione e poteri d’istituzione federata. Non in Svizzera, Austria, Germania o Belgio.
La verità è che le grandi città italiane hanno da sempre utilizzato il ruolo di capoluogo statuale per sfruttare ed opprimere il contado rurale imponendogli subalternità ed emarginazione politica, sociale, culturale ed, ovviamente economica.
Scuole, università, presidi sanitari, teatri, acquedotti, sistemi viari interni ed esterni, tribunali, uffici fiscali, sedi di Banche ed altri uffici dirigenziali con fabbriche ed infrastrutture diverse erano concentrate nelle città; del tutto assenti nel mondo agricolo sul cui operoso e massacrante lavoro s’incrostava però il parassitario sfruttamento della nobiltà cittadina cui non era estraneo l’alto clero delle grandi diocesi. Decime d’ogni genere falcidiavano i raccolti agricoli, mentre quel poco che restava ai produttori era messo in vendita a prezzi di fame.
Ancor oggi, salvo qualche rara eccezione i comuni più importanti d’Italia esercitano attraverso la concentrazione industriale, bancaria, commerciale, culturale, politica ed in certa misura spirituale, ruolo egemone nelle rispettive regioni.
Non a caso sono noti i nomi dei sindaci di Torino, Bologna, Napoli ed altre importanti città mentre solo di recente sono comparsi all’onore della cronaca – non sempre positiva – i nomi di alcuni presidenti di regione mentre la gran parte degli altri è sconosciuta ai più nello stesso territorio regionale.
Il tentativo di perpetuare questo tipo di dominanza prevaricante è venuto allo scoperto con la proposta di dar vita al partito delle “Cento Città”. I protagonisti dell’iniziativa sono ancora lì, con ruoli e prospettive diverse ma temo con gli stessi obiettivi.
Non sembra sia chiaro ai facili assertori di una sorta di federalismo più citato che conosciuto che soggetto primo dello Stato federale è il cittadino quale consapevole protagonista di scelte etico-politiche maturate attraverso il confronto vibrante e coinvolgente delle correnti di pensiero che animano il dibattito e realizzano in spirito di solidarietà gli obiettivi di comune interesse.
Il federalismo è partecipazione, creatività, sacrificio ed entusiasmo, forza vitale di popolo che assume su di sé la responsabilità del decidere in virtù di un potere che tutti coinvolge, nobiltà ed eleva a dignità di cittadini.
Non sono proponibili comuni di serie “A” ed altri di serie “B”. Tutte le istituzioni hanno pari dignità, responsabilità, doveri e diritti nell’ambito delle rispettive circoscrizioni.
Coinvolgere i grandi comuni nel ruolo di stato o regione federata significa dequalificare e deresponsabilizzare la regione nell’assolvimento dell’alto compito di governare, stimolare e definire l’equilibrato sviluppo delle diverse aree economiche e fasce sociali presenti nel suo territorio; dobbiamo contenere ed invertire la conseguente crisi in atto che vede svilupparsi un malsano progressivo inurbamento ed la contestuale desertificazione delle campagne.
È da anni che vado sostenendo l’esigenza che i comuni, tutti i comuni e gli enti intermedi debbono esprimere in sede regionale una assemblea che affianchi il Consiglio regionale e sia costituita da una ventina di rappresentanti eletti dai sindaci e presidenti di provincia – che parallelamente al ruolo nazionale (di cui da federalisti chiediamo l’istituzione) del Senato delle Regioni – partecipi con voto vincolante all’approvazione delle leggi cardine quali la finanziaria, il bilancio, la programmazione e tutte le altre che in qualsivoglia modo coinvolgono le attività istituzionali degli enti locali.
La Regione diventerà così istituzione di alta democrazia perché legittimata dal voto dei cittadini e delle istituzioni che affrontano e risolvono i problemi del quotidiano, definiscono progetti e proposte da portare alla decisione dell’organo legislativo regionale del quale diventano componente essenziale.
Queste a grandi linee sono le ragioni che mi fanno diffidare delle ancor confuse e contraddittorie proposte di federalismo.
Ma anche ipotizzando uno Stato federale modellato sui principi vitalmente qualificanti del potere di autogoverno regionale (o stati federati) garantite nel loro esercizio dalla forza della Costituzione, ritengo ugualmente irrinunciabile lo Statuto speciale sardo.
L’insularità crea problemi e prospettive in larga parte diverse da quelle di tutte le altre regioni italiane.
Basti pensare che da quando il nostro popolo ha perduto la libertà ed è stato assoggettato a dominazioni esterne ha perduto ogni rapporto con il mare diventandone prigioniero tanto che ancora oggi l’isola di Sardegna non ha economia marittima e dipende totalmente dall’esterno per i potenziali processi d’integrazione economica e civile con i paesi rivieraschi del Mediterraneo e di oltre oceano.
Il problema sardo, che va ben oltre l’orizzonte economico può trovare soluzione nelle nostre capacità d’iniziativa rese possibili solo dalla piena autonomia di governo dello sviluppo.
Questo non può, come in altre realtà, realizzarsi in virtù del mercato interno data la vastità del territorio sardo e la modestia numerica della popolazione insediata, ma deve utilizzare – come han sempre fatto tutti i popoli – anzitutto la sua posizione geografica. Limitandomi all’essenziale ne elenco alcune motivazioni: la centralità mediterranea nord occidentale, quale punto di snodo ed incontro di civiltà e commerci fra i continenti d’oltre oceano ed i paesi rivieraschi del Mediterraneo a noi più vicini, con particolare riferimento al Nord Africa.
Dobbiamo attivare una politica fortemente impegnata nel vitalizzare la portualità sarda rendendola competitiva sia da attrarre i traffici marittimi internazionali e fare della Sardegna, in uno con le moderne forme di franchigia fiscale, la Svizzera del Mediterraneo.
Altro potenziale economico è costituito dalla presenza nel nostro territorio di un patrimonio archeologico unico al mondo.
La crescita tumultuosa del turismo costiero dovrà integrarsi con quello culturale delle zone interne ove i turisti scopriranno il fascino misterioso di un popolo che nella preistoria, pur impegnato nell’allevamento del bestiame ovino, caprino e bovino, non si sentiva prigioniero del tempo e del mare; costruiva strutture nuragiche ove regalità e trasfigurazioni religiose testimoniano ricchezza spirituale espressione di una forza interiore capace di guardare oltre l’orizzonte dei millenni.
Sfidava la vastità dei mari per incontrare altri popoli, scambiare con essi commerci e reciproche civiltà, pur vivendo speranze e angosce del quotidiano, trasfuse nella raffinata eleganza delle statuette bronzee nelle quali si esprime la ricchezza creativa di questo popolo: dall’ascetismo del sacerdote orante alla determinazione del guerriero sino al silente dolore della madre che riaccoglie nel suo grembo il corpo del figlio esanime.
I turisti colgono tutta la forza e l’umanità; sono stimolati a vagare fra le ombre del passato vivendo la suggestione del mistero che li lega alla Sardegna con ricordi incancellabili.
Ma, ripeto, il nostro problema va oltre gli aspetti economici, pur rilevanti, complessi ed aperti su tutto l’arco dei processi produttivi da quelli agricoli, industriali e terziari e tecnologici in tumultuosa evoluzione e per incentrarsi nel momento politico.
Lussu ci definì “Nazione mancata”, ma penso si riferisse allo “Stato” mancato.
Infatti noi, secondo l’insegnamento mazziniano, diamo vita alla Nazione Sarda. Un popolo da millenni insediato in territorio conchiuso da precisi confini, protagonista di storia che ha avuto bagliori di civiltà, ed amare, durissime esperienze di dominazioni diverse; pur assoggettato dalla violenza degli eserciti, ha mantenuto vivo il profondo senso di appartenenza ad una sardità diversa ed unica che mai si è inglobata con gli usurpatori. Certo le cosiddette classi dirigenti: politici, intellettuali, operatori economici ed alto clero (d’importazione) vestivano i panni e parlavano la lingua dei padroni di turno. Il popolo no. Ha conservato gelosamente la lingua che pur facendo parte del ceppo della romanità, è profondamente diversa tanto da quella italiana che francese, spagnola e degli altri popoli di cultura neolatina. Siamo i Sardi ed abbiamo nella sofferenza dell’oppressione politica come del disumano sfruttamento economico, elaborato valori etici, forme produttive, organizzazione sociale, poesia e canti originali di struggente bellezza.
Ebbene l’insieme di queste esperienze, maturate nei secoli hanno il palpito vitale della civiltà; quella che si è soliti definire “civiltà pastorale”.
Ne è testimonianza la letteratura narrativa e poetica degli autori sardi affermatasi per i suoi valori universali, nel corso di questo secolo a livello mondiale. Inutile ricordarne i nomi celebri e quelli meno noti (ma non per questo meno significativi) posto che di tutti si può affermare come l’ispirazione dominante vada ricercata nell’intenso rapporto d’amore con la Sardegna, terra madre, amara ed avara che non protegge né gratifica i figli per antica debolezza, bisognosa essa stessa di protezione ed amore. La poetica dei nostri autori è come permeata da un anelito diffuso e costante, un inconfessato ma palpitante protendersi nell’impossibile ritorno in seno ad una maternità incompiuta.
Il movimento politico che si rifà al sardismo muove dallo stesso sentimento. Avvertiamo nel nostro ragionare un rapporto con la terra vissuta come madre ancor prima che Patria. Direi che il momento politico nasce come esigenza di dare percorso razionale all’onda di sentimenti che ci lega alla sardità.
Sono valori spirituali, di norma, assenti nelle realtà ove la civiltà del profitto ha mutato i rapporti fra persone ed ambiente.
Non possiamo rinunziare alla diversità; ad essere noi stessi accettando un conformismo istituzionale che appiattisce le diversità annullandole nell’incombente globalizzazione. Non possiamo ripetere l’errore storico commesso nell’Ottocento quarantotto dalla cosiddetta classe dirigente sarda del tempo che ha rinunziato alla statualità del Regno di Sardegna, distinta da quella del Principato di Piemonte, nell’illusione che i sardi, da coloni dei piemontesi sarebbero diventati piemontesi essi medesimi.
Il nostro impegno oggi è quello di fare dello Statuto sardo lo strumento della nostra sovranità politica, non contrapposta, ma distinta da quella delle altre regioni italiane ed europee, consapevoli di assumere, con la libertà, la responsabilità di trovare in noi stessi, nella nostra fantasia creativa, la forza di un futuro partecipe dei processi evolutivi dell’umanità al cui realizzarsi avremo dato il nostro contributo ricevendone, in solidale reciprocità, la luce di civiltà fiorite in ambienti, territori e popoli sviluppatisi in forme ed esperienze profondamente diverse dalle nostre.
La specialità dello Statuto dovrà arricchirsi sul piano istituzionale dei poteri originari correlati alla sovranità popolare ma altresì adeguarsi alla specificità dei problemi che progresso civile, sviluppo economico, posizione geografica, rapporti interni ed internazionali renderanno necessari per un corretto e funzionale governo di un popolo coinvolto nel dinamico divenire di fecondi rapporti competitivi ma non conflittuali con le altre regioni italiane, europee, mediterranee, nel respiro politico di cittadini partecipi a pieno titolo della cittadinanza universale.
A scrivere le nuove pagine dello Statuto dovrà essere il popolo sardo e non un potere che dall’alto faccia cadere su di noi concessioni implicanti nuove, più moderne e perciò pericolosamente subdole forme di limiti in virtù del principio “ubi ipse non scripsit… non v’è altro spazio d’autonomia”.
Questo tipo di statualità e di regionalismo deve considerarsi finito con l’avvento della federazione europea nella quale saremo chiamati a svolgere un ruolo primario, autonomo ma funzionale alla mediazione intercontinentale fra i paesi rivieraschi del Mediterraneo quale posizione geografica e genesi storica ci assegnano.
Non saremo più periferia italiana né europea ma cuore pulsante della civiltà mediterranea che da sempre è valore dell’intera umanità.